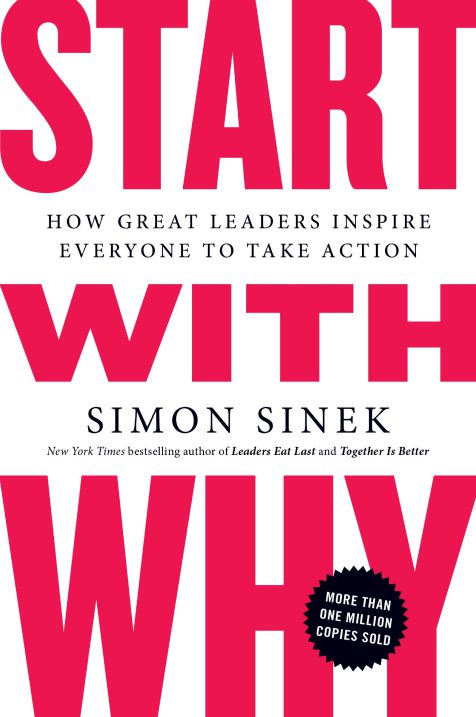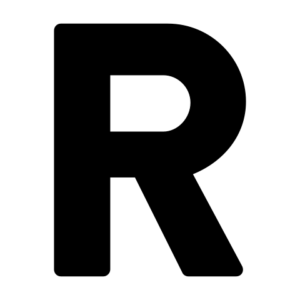Dimenticanza critica: mettere in discussione i tuoi assunti in modo costruttivo
Come sviluppare la dimenticanza critica, comprendere le dinamiche, sospendere le certezze e dare spazio a idee nuove attraverso pratiche quotidiane.

Immagina di svegliarti una mattina in una città che conosci come le tue tasche: le stesse strade, i bar sotto i portici, il campanile che segna le ore con la sua solita regolarità. Ti prendi il caffè, ne apprezzi il sapore e senti il calore della tazzina tra le mani, quasi senza pensarci. Ogni gesto si ripete come un’abitudine, un film che scorre in loop nella mente.
Poi, un giorno e all’improvviso, qualcosa succede: guardi la tazzina e ti chiedi perché, in tutto questo tempo, non hai mai pensato di provare una colazione diversa, passare al cappuccino o creare un rito alternativo.
È un attimo di vertigine, dove qualche certezza vacilla e la realtà assume l'aspetto di un teatro di consuetudini mai messe in discussione. In quello spazio, inatteso, si è aperta la possibilità di rivedere ciò che pensavi, fino a quel momento, immutabile.
Quella scintilla, breve e sorprendente, che si può comprendere, cogliere e trasformala in un seme di cambiamento, un impulso a interrompere il normale per scoprire il nuovo, come esploratori nel mondo che abbiamo creato e che, talvolta, ci imprigiona senza che ce ne rendiamo conto.

L'opportunità di pensare oltre il normale
Ogni giorno viviamo sospesi in una comfort zone con abitudini radicate fin dall’infanzia: percorsi abituali, schemi di pensiero consolidati, risposte rapide a domande che nemmeno ci poniamo più.
Pensare oltre ciò che conosciamo non è strano né riservato ai filosofi: è un modo per mantenere viva la curiosità e affrontare contesti in rapida evoluzione. Viviamo in tempi di cambiamenti continui, crisi costanti, tensioni geopolitiche, innovazioni tecnologiche e rapide trasformazioni ambientali e sociali, e le nostre mappe cognitive e comportamentali, ormai spesso obsolete, potrebbero non essere più sufficienti.
Non si tratta di negare o eliminare la conoscenza o l'esperienza, bensì di mettere in “sospeso” alcune certezze che diamo per scontate per avere la possibilità di osservare la realtà con occhi nuovi.
L’obiettivo principale della dimenticanza critica è, quindi, trasformare il "pensiero automatico" in un pensiero più consapevole ed attivo.
In termini filosofici, questa pratica richiama l’epoché di Edmund Husserl: una sospensione del giudizio che consente di cogliere l’essenza dei fenomeni al di là delle interpretazioni consolidate o in ambito psicologico assomiglia al reframing, ossia alla ricollocazione di un’esperienza in un contesto differente per aprire nuove prospettive interpretative.
È un processo che richiede volontà e allenamento, perché implica il riconoscimento dei filtri (culturali, emotivi e cognitivi) al fine di creare un nuovo spazio mentale in cui possono emergere alternative prima invisibili: nuove soluzioni, domande più profonde e soluzioni creative.

Comprendere gli assunti per metterli in discussione e innovare
Gli assunti nascono all’incrocio tra storia personale, contesto sociale e trama culturale in cui cresciamo. Sin da piccoli, assimiliamo credenze e regole implicite attraverso l’osservazione, l’imitazione e il rinforzo: la famiglia, la scuola e il gruppo di amici ci trasmettono comportamenti, valori, pregiudizi e aspettative. A questi si aggiungono i codici culturali più ampi: religione, istituzioni, media. Ed infine le nostre esperienze passate. Tutto ciò definisce ciò che è considerato da noi “normale”, “giusto” o “possibile”.
In un’ottica di sviluppo, riconoscere e mettere in discussione tali vincoli appresi è fondamentale per attivare processi di trasformazione autentica:
- Prima di tutto, il cervello tende a semplificare, riducendo la complessità del mondo a schemi ripetibili per risparmiare energia cognitiva. Le nuove informazioni vengono rapidamente inserite in categorie preesistenti, perché è più facile etichettare che esplorare ipotesi alternative.
- Inoltre, la familiarità porta a una sorta di cecità percettiva e quando qualcosa ci sembra noto, smettiamo di osservarlo con attenzione, dando per scontato il suo funzionamento e la sua validità. È il motivo per cui le abitudini quotidiane, come il tragitto per andare al lavoro o le frasi che ripetiamo meccanicamente, sfuggono alla nostra consapevolezza.
- A questo si aggiunge il bias di conferma e tendiamo a cercare prove che confermino ciò in cui crediamo già, ignorando o svalutando le informazioni contrastanti. Questo meccanismo rafforza le convinzioni esistenti, creando una sorta di “eco-chamber” che ci protegge dal dubbio.
- Infine, entrano in gioco fattori emotivi e identitari: un’idea consolidata spesso rappresenta una parte del nostro senso di sé e della nostra appartenenza a un gruppo. Metterla in discussione significa rischiare di perdere una parte della nostra identità ed esporsi al giudizio altrui.
Gli assunti sono utili per gestire velocemente la complessità, ma sono anche capaci di congelare l’innovazione e di radicare pregiudizi. Riconoscerne i benefici e i limiti è il primo passo per utilizzare questi meccanismi a nostro favore, aprendoci contemporaneamente ad un senso critico flessibile che alimenta la crescita e l'innovazione.
In letteratura di psicologia comportamentale e sviluppo organizzativo si richiama spesso l’immagine di un elefante vincolato a un semplice paletto durante la sua fase giovanile. Non riuscendo a liberarsi, l’animale apprende l’impossibilità del gesto. Quando diventa adulto e acquisisce la forza necessaria per strappare il vincolo, non tenta più la fuga, convinto che il paletto lo tratterrà ancora.
Pratiche per allenare la dimenticanza critica
Per trasformare la dimenticanza critica in un'abitudine, è utile costruire strumenti e attività concrete capaci di spezzare i circuiti del pensiero automatico:
- Innanzitutto, un diario delle ovvietà per annotare credenze o rituali dati per scontati, seguiti da una breve riflessione sulle loro origini e sul loro possibile ribaltamento. Questo ti allena a riconoscere le convenzioni che spesso ignoriamo.
- In parallelo, dedicare uno spazio alle conversazioni divergenti, cercare un confronto con persone di background culturale, professionale o generazionale differente. Questo stimola la mente a valutare logiche alternative, mettendo in discussione le proprie certezze in modo costruttivo.
- Avvia esplorazioni culturali attraverso documentari, la lettura di romanzi stranieri o la partecipazione a workshop interculturali ampliando il proprio orizzonte, mostrandoci che ciò che consideriamo “normale” è solo una delle tante possibili declinazioni della realtà.
- Dedicati a letture dissonanti, testi che ci disturbano o contraddicono direttamente le nostre opinioni, perché il disagio intellettuale genera fratture capaci di far emergere nuove prospettive.
- Infine, la pratica del silenzio, attraverso momenti di meditazione o semplici pause senza stimoli esterni. Questo libera lo spazio necessario per percepire le resistenze mentali e lasciar emergere nuove intuizioni.
Tramite la varietà di stimoli e riflessione sistematica si costruisce un allenamento alla sospensione attiva del giudizio e alla riscoperta di un pensiero libero e flessibile.

Valutare i segnali di trasformazione
Per valutare i progressi nella bisogna osservare come cambia il nostro modo di percepire e reagire agli stimoli ed alla realtà.
Un primo segnale è la capacità di riconoscere i “piloti automatici” del pensiero: ti rendi conto in tempo reale quando stai agendo secondo schemi consolidati e, invece di seguirli, ti fermi a riflettere sui presupposti che hanno guidato quella reazione.
Un altro indicatore è lo spazio dedicato alle domande piuttosto che alle risposte immediate in una conversazione: inizi a chiederti “Perché penso così?” o “Quali alternative ci sono?”, invece di difendere una posizione predefinita.
La flessibilità cognitiva si manifesta anche nel desiderio di ottenere fonti e punti di vista che prima avresti ignorato: se prima provavi fastidio o rigetto, ora senti curiosità e attenzione.
Infine, un segnale importante è la disponibilità a condividere questi processi con gli altri: confrontarsi sui dubbi diventa un’opportunità di crescita condivisa, dimostrando che la sospensione del giudizio sta diventando parte del tuo approccio.

Un esercizio concreto
Una volta condiviso il valore è possibile mettere in pratica la teoria con una sfida di sette giorni per introdurre gradualmente nuovi livelli di consapevolezza.
- Ogni mattina, dedica cinque minuti al tuo Diario delle ovvietà: annota tre convinzioni o comportamenti che ritieni immutabili e per ciascuno rispondi alle domande “Da dove arriva questo pensiero?” e “In che modo potrei rovesciarlo?”.
- Nel pomeriggio, scegli un interlocutore con un punto di vista differente (un amico di un settore distante dal tuo, un familiare con convinzioni opposte o un collega con background culturale diverso) e avvia una conversazione di almeno dieci minuti per scoprire come interpreta una delle tue ovvietà; ascolta senza difendere subito le tue ragioni, concentrandoti su ciò che ti fa pensare “E se fosse vero?”.
- Ogni sera, riserva quindici minuti a una pratica di silenzio, chiudendo gli occhi e focalizzandoti sul respiro, lasciando emergere dubbi o intuizioni non filtrate.
- Il terzo giorno, scegli un contenuto (un articolo, un estratto di saggio o un TED Talk) che contraddica radicalmente la tua visione su un tema che consideri assodato ma non valoriale; annota le emozioni e i pensieri scatenati, individuando eventuali bias di conferma.
- Il quinto e il sesto giorno, alterna tra l'esplorazione culturale, ad esempio guardando un documentario su una comunità distante dalla tua, e la lettura dissonante di testi provocatori, identificando ciò che per gli altri è "standard" ma non lo è per te.
- Infine, il settimo giorno, rivedi tutte le tue annotazioni: individua i temi ricorrenti, i vecchi schemi che continuano a emergere e i momenti di rottura in cui hai trovato nuove prospettive. Condividi le tue intuizioni con un gruppo di fiducia o sui tuoi canali social, invitando gli altri a partecipare alla sfida.
Questa esperienza ti mostrerà concretamente come, con gesti semplici e costanti, sia possibile rompere gli automatismi mentali e aprire la strada a idee e soluzioni innovative.

Aperti a disimparare temporaneamente
La dimenticanza critica è una pratica che cambia il modo in cui percepiamo noi stessi, gli altri e le sfide quotidiane. Sia nel lavoro che nella vita personale, questo approccio stimola decisioni più consapevoli e strategie creative, incoraggiandoci a superare i limiti predefiniti.
Con il tempo, diventa facile individuare i segnali e sostituirli con domande generative come: “Perché do per scontato questo?” o “Quale prospettiva non ho ancora considerato?”. Se il dubbio diventa alleato anziché ostacolo, si otterrà una maggiore flessibilità mentale, una comunicazione più genuina e una leadership innovativa e aperta alla diversità e alle idee.

Per approfondire

Husserl, Edmund – Idee per una fenomenologia pura (Einaudi, 2002) Fondamentale per comprendere il concetto di epoché, ovvero la messa tra parentesi dei pregiudizi nella fenomenologia.

Zahavi, Dan – La fenomenologia di Husserl (Rubbettino, 2011) Un’ottima introduzione al metodo husserliano e alle sue applicazioni al pensiero critico.
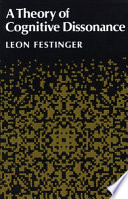
Festinger, Leon – A Theory of Cognitive Dissonance (Stanford University Press, 1957) La base per capire perché resistiamo al cambiamento delle nostre convinzioni.

Kahneman, Daniel – Thinking, Fast and Slow (Farrar, Straus and Giroux, 2011) Spiega i meccanismi del pensiero veloce (“pilota automatico”) e del pensiero lento, utile per esercizi di sospensione critica.